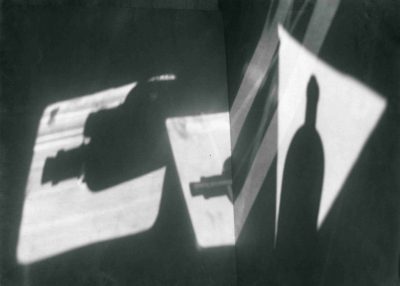A Howard Moss
1
Leggiamo la storia delle nostre vite
che si svolge in una stanza.
La stanza si affaccia su una strada.
Là fuori non c’è nessuno,
non c’è rumore alcuno.
Le piante sono appesantite dalle foglie,
le auto parcheggiate sempre ferme.
Continuiamo a voltar pagina,
sperando vi sia qualcosa,
qualcosa come grazia o mutamento,
una linea nera che ci unisca
o ci separi.
A conti fatti, parrebbe
che il libro delle nostre vite sia vuoto.
I mobili nella stanza non li si sposta mai,
e i tappeti si fanno più scuri ogni volta
che le nostre ombre vi trascorrono.
Pare quasi che la stanza sia il mondo.
Seduti fianco a fianco sul divano,
leggiamo del divano.
Diciamo che è ideale.
È ideale.
2
Leggiamo la storia delle nostre vite
come ne fossimo parte,
come l’avessimo scritta noi.
È un tema ricorrente.
In un capitolo
mi appoggio allo schienale e metto il libro da parte
perché il libro dice che è quello che faccio.
Mi appoggio allo schienale e comincio
a scrivere qualcosa che parla del libro.
Scrivo che vorrei spingermi oltre il libro,
oltre la mia vita in un’altra vita.
Ripongo la penna.
Il libro dice: Lui ripose la penna
e si volse a guardarla leggere
il brano in cui lei si innamorava.
Il libro è più preciso di quanto riusciamo a immaginare.
Mi appoggio allo schienale e ti guardo leggere
qualcosa sull’uomo che sta al di là della strada.
Hanno costruito una casa di là,
e un giorno ne è uscito un uomo.
Ti sei innamorata di lui
perché sapevi non sarebbe mai venuto a trovarti,
non avrebbe mai saputo che attendevi.
Sera dopo sera avresti poi detto
che era come me.
Mi appoggio allo schienale e ti guardo invecchiare senza di me.
Il sole ti si posa sui capelli d’argento.
I tappeti, i mobili,
paiono quasi immaginari, adesso.
Lei continuava a leggere.
Pareva non considerare l’assenza di lui
di particolare importanza,
come chi in una giornata stupenda considera
il tempo un disastro
perché non gli ha fatto cambiare idea.
Strizzi gli occhi.
Hai l’impulso di chiudere il libro
che descrive la mia resistenza:
dice che quando mi appoggio allo schienale immagino
la mia vita senza di te, immagino di trasferirmi
in un’altra vita, un altro libro.
Descrive la tua dipendenza dal desiderio,
dice che le rivelazioni momentanee
di un’intenzione ti impauriscono.
Il libro descrive assai più di quanto dovrebbe.
Il libro vuole separarci.
3
Stamattina al risveglio credevo
che nelle nostre vite non ci fosse altro
che la storia delle nostre vite.
Quando esprimesti disaccordo indicai
il punto nel libro in cui esprimevi disaccordo.
Ti sei riaddormentata e ho iniziato a leggere
quei passi oscuri che solevi provare a indovinare
mentre venivano scritti
e per cui perdevi interesse una volta divenuti
parte della storia.
In un brano vesti fredde di luna
drappeggiano le sedie nella stanza di un uomo.
Lui sogna una donna le cui vesti sono perse,
e che siede in giardino e aspetta.
Lei crede che amore sia sacrificio.
Il brano descrive la sua morte
e lei non viene mai nominata,
e questa è una delle cose
che di lei non si sopportano.
Poco dopo veniamo a sapere
che l’uomo che sogna abita
nella casa nuova di fronte.
Stamattina dopo che ti sei riaddormentata
ho cominciato a sfogliare la prima parte del libro:
era come sfogliare l’infanzia,
tante di quelle cose parevano svanite,
tante di quelle cose parevano ritornare in vita.
Non sapevo che fare.
Il libro diceva: In quegli attimi era il libro dell’uomo.
Una corona tetra gli cingeva sgradevole la testa.
Era il breve sovrano della discordia interiore ed esteriore,
pavido nel proprio regno.
4
Prima che ti svegliassi
ho letto un altro passo che descriveva la tua assenza
e raccontava che dormi per invertire
il fluire della tua vita.
Mi sono commosso per la mia solitudine nel leggerlo,
conscio che ciò che provo è la forma grezza
e mal riuscita di una storia
che potrebbe non venir mai raccontata.
Leggevo e mi commuovevo al desiderio di offrirmi
alla casa del tuo sonno.
Voleva vederla nuda e vulnerabile,
vederla nelle trame accantonate, scartate
dei vecchi sogni, i costumi e le maschere
di stati irraggiungibili.
Era come se venissero irresistibilmente
attratti dal fallimento.
Era difficile continuare a leggere.
Ero stanco e volevo rinunciare.
Il libro pareva rendersene conto.
Accennai a cambiare argomento.
Ho atteso che ti svegliassi senza sapere
quanto ho aspettato,
e pareva che non stessi più leggendo.
Sentivo il vento passare
come un flusso di sospiri
e sentivo il brivido delle foglie
sull’albero oltre la finestra.
Nel libro lo si sarebbe ritrovato.
Vi si sarebbe ritrovato tutto.
Ho guardato il tuo volto
e ho letto gli occhi, il naso, la bocca…
5
Se solo vi fosse un attimo perfetto nel libro;
se solo potessimo vivere in quell’attimo,
potremmo ricominciare il libro
come se non l’avessimo scritto,
come se non fossimo in esso.
Ma gli accessi oscuri
a ogni pagina sono troppo numerosi
e le vie di fuga troppo anguste.
Leggiamo tutto il giorno.
Ogni pagina girata è una candela
che ci si muove nella mente.
Ogni attimo è una causa persa.
Se solo potessimo smettere di leggere.
Lui non volle mai leggere altro libro
e lei continuava a fissare la strada.
Le auto c’erano ancora,
le copriva l’ombra fitta degli alberi.
Le imposte della casa nuova erano chiuse.
Forse l’uomo che vi abitava,
l’uomo che lei amava, leggeva
la storia di un’altra vita.
Lei immaginava un salotto spoglio,
un caminetto freddo, un uomo seduto
a scrivere una lettera a una donna
che ha sacrificato la vita per amore.
Se vi fosse un attimo perfetto nel libro,
sarebbe l’ultimo.
Il libro non parla mai delle cause dell’amore.
Sostiene che la confusione è un bene necessario.
Non spiega mai. Rivela.
6
II giorno continua.
Studiamo quel che ci ricordiamo.
Guardiamo nello specchio oltre la stanza.
Non sopportiamo d’essere soli.
Il libro continua.
Ammutolirono senza sapere come iniziare
il dialogo necessario.
Erano le parole soprattutto a creare divisioni,
a creare solitudine.
Attendevano.
Voltavano le pagine nella speranza
che accadesse qualcosa.
Rattoppavano le loro vite in segreto:
ogni sconfitta perdonata perché non poteva essere messa alla prova,
ogni dolore premiato perché irreale.
Non facevano nulla.
7
Il libro non sopravviverà.
Ne siamo prova vivente.
È buio fuori, nella stanza è più buio.
Sento che respiri.
Mi chiedi se sono stanco,
se voglio leggere ancora.
Sì, sono stanco.
Sì, voglio leggere ancora.
Dico sì a tutto.
Non puoi sentirmi.
Stavano seduti fianco a fianco sul divano.
Erano le copie, gli spettri esausti
di qualcosa che erano stati in precedenza.
Assumevano atteggiamenti spossati.
Fissavano il libro
ed erano orripilati dalla propria ingenuità,
dalla riluttanza ad arrendersi.
Stavano seduti fianco a fianco sul divano.
Erano decisi ad accettare la verità.
Qualunque fosse l’avrebbero accettata.
Il libro lo si sarebbe dovuto scrivere
e lo si sarebbe dovuto leggere.
Sono loro il libro e non sono
niente altro.
Mark Strand
(Traduzione di Damiano Abeni)
da “L’inizio di una sedia”, Donzelli Poesia, 1999
∗∗∗
The story of our lives
for Howard Moss
1
We are reading the story of our lives
which takes place in a room.
The room looks out on a street.
There is no one there,
no sound of anything.
The trees are heavy with leaves,
the parked cars never move.
We keep turning the pages,
hoping for something,
something like mercy or change,
a black line that would bind us
or keep us apart.
The way it is, it would seem
the book of our lives is empty.
The furniture in the room is never shifted,
and the rugs become darker each time
our shadows pass over them.
It is almost as if the room were the world.
We sit beside each other on the couch,
reading about the couch.
We say it is ideal.
It is ideal.
2
We are reading the story of our lives
as though we were in it,
as though we had written it.
This comes up again and again.
In one of the chapters
I lean back and push the book aside
because the book says
it is what I am doing.
I lean back and begin to write about the book.
I write that I wish to move beyond the book,
beyond my life into another life.
I put the pen down.
The book says: He put the pen down
and turned and watched her reading
the part about herself falling in love.
The book is more accurate than we can imagine.
I lean back and watch you read
about the man across the street.
They built a house there,
and one day a man walked out of it.
You fell in love with him
because you knew he would never visit you,
would never know you were waiting.
Night after night you would say
that he was like me.
I lean back and watch you grow older without me.
Sunlight falls on your silver hair.
The rugs, the furniture,
seem almost imaginary now.
She continued to read.
She seemed to consider his absence
of no special importance,
as someone on a perfect day will consider
the weather a failure
because it did not change his mind.
You narrow your eyes.
You have the impulse to close the book
which describes my resistance:
how when I lean back I imagine
my life without you, imagine moving
into another life, another book.
It describes your dependence on desire,
how the momentary disclosures
of purpose make you afraid.
The book describes much more than it should.
It wants to divide us.
3
This morning I woke and believed
there was no more to our lives
than the story of our lives.
When you disagreed, I pointed
to the place in the book where you disagreed.
You fell back to sleep and I began to read
those mysterious parts you used to guess at
while they were being written
and lose interest in after they became
part of the story.
In one of them cold dresses of moonlight
are draped over the backs of chairs in a man’s room.
He dreams of a woman whose dresses are lost,
who sits on a stone bench in a garden
and believes in wonders.
For her love is a sacrifice.
The part describes her death
and she is never named,
which is one of the things
you could not stand about her.
A little later we learn
that the dreaming man lives
in the new house across the street.
This morning after you fell back to sleep
I began to turn pages early in the book:
it was like dreaming of childhood,
so much seemed to vanish,
so much seemed to come to life again.
I did not know what to do.
The book said: In those moments it was his book.
A bleak crown rested uneasily on his head.
He was the brief ruler of inner and outer discord,
anxious in his own kingdom.
4
Before you woke
I read another part that described your absence
and told how you sleep to reverse
the progress of your life.
I was touched by my own loneliness as I read,
knowing that what I feel is often the crude
and unsuccessful form of a story
that may never be told.
I read and was moved by a desire to offer myself
to the house of your sleep.
He wanted to see her naked and vulnerable,
to see her in the refuse, the discarded
plots of old dreams, the costumes and masks
of unattainable states.
It was as if he were drawn
irresistibly to failure.
It was hard to keep reading.
I was tired and wanted to give up.
The book seemed aware of this.
It hinted at changing the subject.
I waited for you to wake not knowing
how long I waited,
and it seemed that I was no longer reading.
I heard the wind passing
like a stream of sighs
and I heard the shiver of leaves
in the trees outside the window.
It would be in the book.
Everything would be there.
I looked at your face
and I read the eyes, the nose, the mouth…
5
If only there were a perfect moment in the book;
if only we could live in that moment,
we could begin the book again
as if we had not written it,
as if we were not in it.
But the dark approaches
to any page are too numerous
and the escapes are too narrow.
We read through the day.
Each page turning is like a candle
moving through the mind.
Each moment is like a hopeless cause.
If only we could stop reading.
He never wanted to read another book
and she kept staring into the street.
The cars were still there,
the deep shade of trees covered them.
The shades were drawn in the new house.
Maybe the man who lived there,
the man she loved, was reading
the story of another life.
She imagined a dank, heartless parlor,
a cold fireplace, a man sitting
writing a letter to a woman
who has sacrificed her life for love.
If there were a perfect moment in the book,
it would be the last.
The book never discusses the causes of love.
It claims confusion is a necessary good.
It never explains. It only reveals.
6
The day goes on.
We study what we remember.
We look into the mirror across the room.
We cannot bear to be alone.
The book goes on.
They became silent and did not know how to begin
the dialogue which was necessary.
It was words that created divisions in the first place,
that created loneliness.
They waited.
They would turn the pages, hoping
something would happen.
They would patch up their lives in secret:
each defeat forgiven because it could not be tested,
each pain rewarded because it was unreal.
They did nothing.
7
The book will not survive.
We are the living proof of that.
It is dark outside, in the room it is darker.
I hear your breathing.
You are asking me if I am tired,
if I want to keep reading.
Yes, I am tired.
Yes, I want to keep reading.
I say yes to everything.
You cannot hear me.
They sat beside each other on the couch.
They were the copy, the tired phantoms
of something they had been before.
The attitudes they took were jaded.
They stared into the book
and were horrified by their innocence,
their reluctance to give up.
They sat beside each other on the couch.
They were determined to accept the truth.
Whatever it was they would accept it.
The book would have to be written
and would have to be read.
They are the book and they are
nothing else.
Mark Strand
da “The Story of Our Lives”, Atheneum, 1973