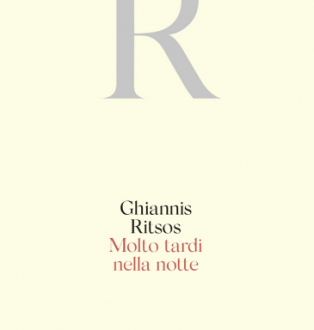Grèce, ô mère des arts! terre d’idolâtrie,
De mes vœux insensés éternelle patrie…
ALFRED DE MUSSET, Les Vœux stériles
Forse ho raggiunto l’età in cui gli occhi si sono inariditi per sempre, come fiori secchi schiacciati tra le pagine di un libro. Forse ho dimenticato… ma credo che mai dei versi, per quanto belli, per quanto commoventi fossero, mi abbiano fatto piangere. Senza dubbio, ero più sensibile alla bellezza delle parole, al gioco sonoro, che non all’emozione provata, alla tragedia dei termini. Mi è capitato in una occasione, è vero, anche se non è di questo che intendo parlare: ne fu responsabile una poesia di André Breton, e non la prima volta che la ebbi sotto gli occhi, ma nel rileggerla in seguito, quando io e il suo autore eravamo già divisi l’uno dall’altro come le foglie di uno stesso albero strappate dalla violenza del vento esterno. Si intitolava L’Union libre, e ripeto che non è di questo che voglio parlare.
Più di vent’anni fa, dunque, mi portarono, tradotti dal greco, i versi di un poeta che non conoscevo affatto: dovevo correggere il francese della traduzione. Tutt’a un tratto quella poesia mi fece venire un nodo alla gola, e lo strano fu che in seguito, quasi ogni volta che mi toccò rivedere i versi più o meno ben tradotti di questo sconosciuto, mi sono sempre sentito, come la prima volta, incapace di padroneggiare i miei occhi, di trattenere le lacrime. Ai tempi di quella prima volta Ghiannis Ritsos, di cui non sapevo nulla, era deportato nelle isole, o in prigione da qualche parte, ma, che mi crediate o no, io l’avevo dimenticato… non era per questa ragione, ve lo giuro, non era per questa ragione! Quante volte in seguito la cosa si è ripetuta? È come se questo poeta possedesse il segreto della mia anima, come se lui solo sapesse, lui solo, capite, turbarmi in questo modo. Ignoravo inoltre che fosse il più grande poeta vivente di questo tempo che è il nostro; giuro che non lo sapevo. L’ho appreso a tappe, andando da una poesia all’altra, stavo per dire da un segreto all’altro, perché ogni volta era il turbamento di una rivelazione quello che provavo. La rivelazione di un uomo, e quella di un Paese, le profondità di un uomo, e quelle di un Paese.
La Grecia, a noi francesi, fa battere il cuore da centocinquant’anni, e cioè dalla proclamazione della sua indipendenza, e i poeti di casa nostra, dai tempi delle Orientales, l’hanno sognata come la sognano oggi, oggi che da essa ci giungono, malgrado tutto, le voci della libertà. E senza dubbio non siamo soli: era forse solo Victor Hugo quando c’era Byron, e c’era stato Hölderlin? Ma senza dubbio il nostro amore era straniero, udiva solo il sibilo dei proiettili, si nutriva ancora soltanto dell’antica lezione dei sogni ellenici, del canto dei nomi degli dèi frammisti a quelli degli eroi, e sì, da gran tempo il nostro orecchio era ebbro dei nomi sacri di epoche trascorse, e come avremmo potuto intendere il canto greco se non identificandolo con quello di cui si erano nutrite le nostre infanzie:
La figlia di Minosse e di Pasifàe…
E non bisogna trascurare nulla, né la traduzione di Racine, né l’ebbrezza dei nomi nei versi di André Chénier… Ma oggi il mondo è cambiato, e anche i sogni. Ho imparato più da voi, fratelli ora vicini, dai vostri cantori, che non dal grido possente dei nostri aedi giunto attraverso i secoli. Ma da nessuno ho imparato come da Ritsos, perché lui è tutta la vita di un popolo, e il suo canto, i suoi dolori.
L’arte di Ritsos va oltre le definizioni: dalle grandi poesie che negli anni Cinquanta gli valsero – era da poco uscito da un campo di concentramento – il Gran premio nazionale greco di poesia, fino a questi brevi singhiozzi degli ultimi tempi, il genere di versi che si può scrivere usando le ginocchia come tavolo nelle isole, quando queste isole si chiamano Makrònissos, Ghiaros, Leros…
Ognuno vi troverà il proprio cuore e la propria piaga. Ricordo quella poesia straordinaria sui ciprioti in lotta contro gli occupanti inglesi, un patriota nascosto in una caverna dove finirà per morire affumicato, bruciato, le parole dell’ultimo momento che l’eroe non ha potuto pronunciare, ma che hanno così poco a che fare, per la loro stessa grandezza, con la letteratura eroica… come sempre, in Ritsos, dove il patetico è nella semplicità delle cose… ma non la preferisco certo, per esempio, a La Sonata al chiaro di luna, che è soltanto il sussurro di un’esistenza comune; e poi ci sono tutte le poesie che parlano di una casa, di un essere umano di cui non c’è altro da raccontare che la vita. Come sono orgoglioso di averle conosciute un po’ prima di tutti gli altri, da un capo all’altro dell’Europa, come se il dio-toro me le avesse portate sulla sua schiena possente! Sono qui, davanti ai pochi libri di suoi versi pubblicati in questo Paese, e attraverso i quali altri Paesi hanno saputo che c’è ancora in Grecia un canto nato per durare secoli… sono qui, davanti a questi pezzi di carta, a questi manoscritti, a queste lettere, come se non esistesse niente di più prezioso al mondo, come se la scrittura trasparente e pura, che sembra smentire sempre l’impassibilità del volto, la bellezza delle statue, non fosse velata dal gocciare delle lacrime. A una a una. Senza clamore. Come una lunga, ammirevole modulazione del silenzio…
In questi ultimi anni abbiamo provato paura, un’orribile paura per lui, per Ritsos, che io ho forse il diritto, pur senza averlo mai conosciuto, di chiamare mio amico, così come ci vantiamo, così come ci permettiamo di amare un fratello sconosciuto che abbiamo solo sentito, qualche volta, passare cantando nella notte. Le poesie di questo periodo sono raccolte in questo libro, al quale non altro titolo si è voluto dare che la giustapposizione dei titoli delle tre parti che lo compongono: Pietre Ripetizioni Sbarre… In quest’ultima, a mio avviso, più che mai prima il canto di Ritsos è stato colto nella sua essenza originaria, e più che mai trasferito nella nostra essenza, nel nostro canto. Dalla Francia abbiamo lanciato un appello, con voce più alta forse e più forte di quelle levatesi da altri Paesi, associando nell’invocazione ai nostri i nomi di un Arthur Rubinstein e di un Rostropovič. In questo momento Ritsos, deportato prima a Leros, e tenuto poi prigioniero a Samo nella casa di sua moglie, che è medico, è già stato trasportato ad Atene, come noi chiedevamo, per curarsi del male di cui soffre da molto tempo, ed è libero, o per lo meno libero di muoversi in quella città che gli è vietato lasciare, ma dove tuttavia può ricevere tutte le cure necessarie e salvarsi. È anche vero però che ogni sua poesia che ci giunge è un miracolo, e che noi temiamo che un giorno il tempo dei miracoli finisca. Il fatto che in Francia si sia ritenuto necessario pubblicare ogni poesia con il testo greco a fronte, che qui si sia voluto far dono ai lettori di questa musica per gli occhi, testimonia sia di un antico amore dei francesi per la Grecia, nostra sorella maggiore, per l’arte, il canto, la poesia di questo Paese, sia della grandezza di un poeta per merito del quale essa rimane, in tutte le vicissitudini dei tempi e delle sfortune umane, ciò che fu, che è, e che saremo insieme.
Bisognerebbe considerare il triplice titolo: Pietre Ripetizioni Sbarre per potersi fare un’idea dei due anni di creazione in condizioni singolari, così come si apre una porta dopo l’altra sul segreto delle camere di una stessa casa. Pietre… ossessione delle statue morte, dei pavimenti, delle colonne spezzate. Io lo intendo così, questo silenzio in cui l’erba cresce e diventa secca, ma più come un silenzio di uomini che di rovine. Una vita al di là della vita, come quella di colui che sarei troppo crudele con me stesso a riconoscere:
prima di dormire e al risveglio, continuava
regolarmente a lavarsi i denti col vecchio spazzolino spelacchiato.
Oh, nulla è più terribile a dirsi, e ben presto noi non saremo nemmeno queste pietre, queste macerie di ciò che fummo. Viene ora la seconda stazione della Via Crucis, la lunga tappa nella quale i passi sono chiamati Ripetizioni, e di cui sento perfettamente l’eco prodotta nel salire; voglio anzi dire di che cosa sono l’eco: dell’altra Grecia, di quella antica, dove tutto diventa amara immagine del presente, anche se noi (dice lui) non siamo prole divina, ma figli di mortali:
Non ci sentiamo affatto
inferiori, non abbassiamo gli occhi. Nostre uniche pergamene
tre parole: Makrònissos, Ghiaros e Leros. E se maldestri
dovessero sembrarvi un giorno i nostri versi, ricordate solo che furono scritti
sotto il naso delle guardie, la baionetta puntata sempre alle costole.
C’è bisogno di commentare queste parole, questa scusa per la fuga nel passato? Ho conosciuto tempi simili, in cui non avevamo l’aria di parlare della nostra vita, come contrabbandieri che (sotto il naso delle guardie) giudici presuntuosi disprezzavano senza accorgersi del cuore che batteva dietro le parole. Ripetizioni… il tempo è passato, non si avverte più il dolore, qui non si sente più battere neanche il cuore… ah. Allora viene la terza tappa, e bisogna ben mostrare le Sbarre perché domani, più tardi, si riconosca, dalle sbarre, la prigione.
Louis Aragon
© Per la prefazione di Louis Aragon, Gallimard, Paris 1971
da “Pietre Ripetizioni Sbarre”, Crocetti Editore, 2020
Titolo dell’opera originale: Πέτρες Eπαναλήψεις Kιγχλίδωμα © Ery Ritsou, 1970