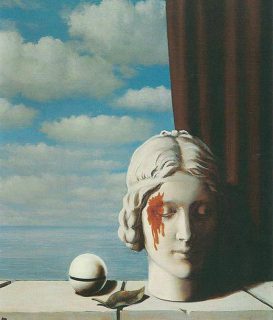Donata Wenders, Peter Handke, Chaville, France, 2009
In ricordo di René Kalisky,
poco tempo dopo essere passato
davanti alla sua abitazione abbandonata
È da tanto che voglio scrivere qualcosa sulla durata,
non un saggio, non un testo teatrale, non una storia –
la durata induce alla poesia.
Voglio interrogarmi con un canto,
voglio ricordare con un canto,
dire e affidare a un canto
cos’è la durata.
Quante volte ho avvertito la durata
nei primi segni di primavera alla Fontaine Sainte-Marie,
nel vento notturno della Porte d’Auteuil,
nel sole estivo del Carso,
nell’incamminarmi all’alba verso casa dopo un’intesa.
Quel senso di durata, cos’era?
Era un periodo di tempo?
Qualcosa di misurabile? Una certezza?
No, la durata era una sensazione,
la piú fugace di tutte le sensazioni,
spesso piú veloce di un attimo,
non prevedibile, non controllabile,
inafferrabile, non misurabile.
Eppure con il suo aiuto
avrei potuto affrontare sorridendo ogni avversario
e disarmarlo
e se mi considerava un uomo malvagio
l’avrei convinto a pensare:
«Egli è buono!»
e se esistesse un Dio
sarei stato la sua creatura
finché provavo quella sensazione della durata.
Proprio ieri nel Waagplatz a Salisburgo
nel frastuono della folla sempre intenta a far la spesa,
udendo una voce
come proveniente dall’altra parte della città
chiamare il mio nome,
mi sono accorto in quello stesso istante
di aver dimenticato su una bancarella
il testo della Ripetizione
che stavo portando alla posta
e nel tornare indietro di corsa ho sentito quell’altra voce
che un quarto di secolo prima
nel silenzio notturno di un sobborgo di Graz,
dall’altro capo di una lunga strada diritta e deserta,
si era rivolta a me con eguale premura e come dall’alto
e mi venne cosí di descrivere
la sensazione della durata
come il momento in cui ci si mette in ascolto,
il momento in cui ci si raccoglie in se stessi,
in cui ci si sente avvolgere,
il momento in cui ci si sente raggiungere
da cosa? Da un sole in piú,
da un vento fresco,
da un delicato accordo senza suono
in cui tutte le dissonanze si compongono e si fondono assieme.
«Ci vogliono giorni, passano anni»:
Goethe, mio eroe
e maestro del dire essenziale,
anche questa volta hai colto nel segno:
la durata ha a che fare con gli anni,
con i decenni, con il tempo della nostra vita:
ecco, la durata è la sensazione di vivere.
Inutile forse dire
che la durata non nasce
dalle catastrofi di ogni giorno,
dal ripetersi delle contrarietà,
dal riaccendersi di nuovi conflitti,
dal conteggio delle vittime.
Il treno in ritardo come al solito,
l’auto che di nuovo ti schizza addosso
lo sporco di una pozzanghera,
il vigile che col dito ti fa cenno
dall’altro lato della strada, uno con i baffi
(non quello ben rasato di ieri),
la morchella che ogni anno rispunta
in un angolo diverso nel folto del giardino,
il cane del vicino che ogni mattina ti ringhia contro,
i geloni dei bambini che ogni inverno
tornano a pizzicare,
quel sogno terrorizzante sempre uguale
di perdere la donna amata,
l’eterno nostro sentirci improvvisamente estranei
fra un respiro e l’altro,
lo squallore del ritorno nel tuo paese
dopo i tuoi viaggi di esplorazione del mondo,
quelle miriadi di morti anticipate
di notte prima del canto degli uccelli,
ogni giorno la radio che racconta un attentato,
ogni giorno uno scolaro investito,
ogni giorno gli sguardi cattivi dello sconosciuto:
è vero che tutto questo non passa
– non passerà mai, non finirà mai –,
ma non ha la forza della durata,
non emana il calore della durata,
non dà il conforto della durata.
Necessario invece distinguere:
neanche «i prodigi mirabili dell’attimo,
nemmeno loro sanno generare ciò che dura
e appaga con la forza della quiete».
Hubert e Felix, l’estate scorsa
costeggiando la Turchia con una barca a vela
avevano gettato l’ancora in una piccola insenatura
per raggiungere la riva con il canotto.
Era – come per tutte e due le settimane –
una giornata senza nubi, calda e leggermente ventosa
e ci eravamo incamminati verso la baia vicina risalendo una collina.
Per strada raccolsi salvia selvatica e mentuccia
con cui poi Felix, candido e bravissimo cuoco,
piú tardi in barca avrebbe insaporito l’astice.
Sull’altra baia vi era un albero di mandorle
dai gusci semiaperti come cozze all’aria.
Mi arrampicai sull’albero per scuoterne i rami
e quello scroscio e quel grandinio sul terreno là sotto
ancora oggi, tornato nella fredda aria continentale,
mi risuonano nelle orecchie.
Tutti e tre nuotammo poi in quel mare color vino,
beati e anche un po’ imbarazzati da tanta beatitudine.
Sulla via del ritorno cogliemmo l’uva
da una vite che saliva intrecciandosi attorno agli alberi della manna,
cogliemmo fichi gialli e bluastri
attorniati da calabroni ronzanti,
assediati da caproni invidiosi di quei frutti,
cogliemmo non ancora mature le melagrane con la corona,
insegne della nostra presenza pura,
cogliemmo i frutti lunghi e scuri del carrubo
dai semi lucidi e durissimi simili a lenticchie
e tornammo con le mani piene di tutto quello
che doveva essere l’epilogo di un pasto straordinario
alla nostra riva
per restarvi ancora a lungo
volgendo lo sguardo verso la barca coperta dal tendale per il sole
e poi d’intorno verso l’interno del paese tremolante di calura
col suo frinire di cicale,
con la rovina di una chiesa bizantina,
il sarcofago licio
– una barca di pietra arenata con la chiglia all’insú
quasi irriconoscibile fra le altre forme di roccia –
e le coperte scure
dei nomadi estivi d’oggi
stese tra le fronde degli alberi,
– nelle narici il profumo delle erbe
e il lezzo
dei resti putrefatti
– le zampe, il sangue, le pelli, –
degli agnelli macellati per noi turisti,
ascoltando il gorgoglio di una fontana
ed il ronzio di un nugolo
di sottili calabroni turchi intorno all’acqua.
Straordinaria mattinata quella,
e ti ho capito allora, Hubert,
appassionato di miti e di confronti,
quando hai definito «biblico» quel luogo:
non occorreva comparissero
i profeti e Rachele alla fonte –
la scena parlava da sé.
Ma la mia commozione e la mia gratitudine
non erano pure:
erano turbate da un’angoscia,
da una malinconia e da un dolore
che mi impietrivano.
Mi sembrava di essere fuori dal mondo,
scacciato per sempre,
come se con questi attimi avessi perduto
il diritto di essere in vita.
Mi sembrava di morire,
ma non di felicità.
Avrei voluto cacciare la testa nell’elica di una barca
cosí come una volta avevo voluto
passare con la testa attraverso la vetrata di una torre panoramica
e separarmi in tal modo dalla bellezza,
dalla terra, dal paradiso,
dalla città santa di Sion, dall’amore ingannevole.
E questo stato d’animo non passava.
Per il resto del viaggio restai assente,
gli occhi sbarrati dallo sgomento,
il cuore un maligno debole battito,
soltanto uno spettro di vita, come tante altre volte mentre lavoro
nel cantuccio quotidiano
chino sulle parole,
sulle definizioni piú antiche,
le parole primigenie di Eschilo, figlio dell’uomo:
«la terra madre di ogni cosa», «il ridere infinito delle onde del mare»
al chiarore rinnovantesi
del nostro «balenio» attraverso il suo vecchio «occhio d’astro» greco.
No, quel giorno provando tutto questo capivo
che al miracolo mancava la durata.
Ero riuscito sí a fermare l’attimo,
ma nemmeno cosí
avevo qualche diritto su di lui.
A casa, subito a casa, pensavo,
tornare nel povero giardino
con la sua erba alta dalle spighe grigie,
le spore del dente di leone (con un resto raggrinzito del suo fiore),
con le sue ortiche (covo di farfalle) e il viluppo sempre piú intricato delle loro radici
e le gocce di rugiada turgide
con la loro pellicola argentea tutta tesa
nelle foglie ad imbuto dell’erba stella
che avevo abbandonato
per questo splendore mediterraneo non destinato a me,
perdendomi la fioritura della malva azzurrina, della malva rossa, delle minuscole bianche labbra del timo,
il maturare dei grappoli di sambuco
(il cespuglio pieno di merli che becchettano),
dei cespugli di nocciole con il loro collare increspato
(il cespuglio pieno di scoiattoli che sputacchiano),
delle pere regina
(l’albero invaso da un brulichio di vespe,
il terreno pieno di lumache che sbavano)
e anche il frusciare autunnale
delle prime foglie secche dell’albero di noce.
Ancora una volta ho capito
che l’estasi è sempre un che di troppo,
è la durata invece la cosa giusta.
Eppure l’accenno al giardino di casa
non vuol significare
che si possa raggiungere la durata
con una residenza stabile
e con le abitudini.
È vero che essa deriva da atti quotidiani ripetuti
attraverso gli anni,
ma non dipende dalla permanenza in un luogo
e da itinerari consueti.
Mai ho sentito la durata
standomene al mio solito posto
– in quello star seduto in silenzio
che si dice faccia diventare «santi» –,
mai ho sentito la durata
seduto a un tavolo riservato ai clienti abituali
– i relativi cartellini,
con tutto il rispetto per le trattorie,
mi sono insopportabili –,
non ho mai sentito la durata
consumando le «pietanze favorite»,
ascoltando la «canzone preferita»,
passeggiando lungo la «mia» strada.
Certo, la durata è l’avventura del passare degli anni,
l’avventura della quotidianità,
ma non è un’avventura dell’ozio,
non è un’avventura del tempo libero (per quanto attivo).
È dunque connessa col lavoro,
con la fatica, con l’impegno, con la continua disponibilità?
No, perché se avesse una regola
richiederebbe allora un paragrafo
e non una poesia.
Io infatti l’ho vissuta anche viaggiando,
sognando, tendendo l’orecchio,
giocando, contemplando,
in un campo sportivo, in una chiesa,
in molti pissoirs.
Vorrei avvicinarmi comunque
all’essenza della durata,
potervi accennare, parlarne nel modo giusto,
farla vibrare,
quell’essenza che ogni volta mi ridà slancio.
Eppure in un primo momento mi viene di intonare
soltanto una litania fatta di singole parole:
sorgente, prima neve, passeri, piantaggine,
albeggiare, imbrunire, benda sterile, accordo.
Sulla durata non si può fare alcun affidamento:
nemmeno la persona religiosa
che va ogni giorno a messa,
neppure chi è paziente, l’artista dell’attesa,
nemmeno colui che ti è fedele
e che senza esitazioni sarà sempre con te,
può averne la certezza per tutta la vita.
Credo di capire
che essa diventa possibile solo
quando riesco
a restare fedele a ciò che riguarda me stesso,
quando riesco a essere cauto,
attento, lento,
sempre del tutto presente a me stesso sino nelle punte delle dita.
E qual è la cosa
a cui devo restare fedele?
Essa ti apparirà nell’affetto
per i vivi
– per uno di loro –
e nella consapevolezza di un legame
(anche soltanto illusorio).
E questa non è una cosa grande
particolare, non è insolita, sovrumana,
non è guerra, non è un allunaggio,
non è una scoperta, un capolavoro del secolo,
la conquista di una vetta, un volo da kamikaze:
io la condivido con altri milioni di persone,
con il mio vicino e allo stesso tempo
con gli abitanti ai margini del mondo,
dove grazie a questo fatto comune
si crea lo stesso centro del mondo
che è qui accanto a me.
Sí, questo fatto dal quale con gli anni scaturisce la durata
è di per sé poco appariscente,
non fa conto parlarne
ma è degno di essere affidato alla scrittura:
perché dovrà essere per me la cosa piú importante.
Dovrà essere il mio vero amore.
E io,
affinché da me nascano i momenti della durata
e diano un’espressione al mio volto rigido
e mettano nel mio petto vuoto un cuore,
devo assolutamente esercitare
un anno dopo l’altro
il mio amore.
Restando fedele
a ciò che mi è caro e che è la cosa piú importante,
impedendo in tal maniera che si cancelli con gli anni,
sentirò poi forse
del tutto inatteso
il brivido della durata
e ogni volta per gesti di poco conto
nel chiudere con cautela la porta,
nello sbucciare con cura una mela,
nel varcare con attenzione la soglia,
nel chinarmi a raccogliere un filo.
Il canto della durata è una poesia d’amore.
Parla di un amore al primo sguardo
seguito da numerosi altri primi sguardi.
E questo amore
ha la sua durata non in qualche atto,
ma piuttosto in un prima e in un dopo,
dove per il diverso senso del tempo di quando si ama,
il prima era anche un dopo
e il dopo anche un prima.
Ci eravamo già uniti
prima di esserci uniti,
continuavamo ad unirci
dopo esserci uniti
giacendo cosí per anni
fianco a fianco, il respiro nel respiro
uno accanto all’altra.
I tuoi capelli bruni si coloravano di rosso
e diventavano biondi.
Le tue cicatrici si moltiplicavano
e diventavano poi introvabili.
La tua voce tremava,
si fece ferma, sussurrava, trasaliva,
si volgeva in una cantilena,
era l’unico suono nella notte del mondo,
taceva al mio fianco.
I tuoi capelli lisci diventarono ricci,
i tuoi occhi chiari diventarono scuri,
i tuoi denti grandi si fecero piccoli.
Sulle tue labbra tese
apparve un disegno fine e delicato,
sul mento sempre liscio
scoprii al tatto una fossetta che prima non c’era
e i nostri corpi invece di farsi male a vicenda
diventavano giocando uno solo,
mentre sulla parete della stanza
alla luce dei lampioni
si muovevano le ombre dei cespugli dei giardini d’Europa,
le ombre degli alberi d’America,
le ombre degli uccelli notturni di ogni dove.
Eppure la durata
non è legata all’amore tra i sessi.
Essa può in egual modo
avvolgerti nel continuo esercizio dell’amore per tuo figlio
e anche in questo caso non certo con le coccole,
i baci, le carezze,
ma anche qui soltanto attraverso cose secondarie,
arrivando alla strada maestra per vie traverse,
l’atto d’amore
per cui servendolo lasci in pace il tuo bambino.
La durata accanto a tuo figlio
rivive forse
nei momenti di ascolto paziente,
nell’attimo in cui tu
con lo stesso gesto accurato
col quale dieci anni fa
appendevi all’attaccapanni
il cappotto azzurro con cappuccio «taglia bambino»,
adesso appendi una giacca di pelle scura «taglia adulto»
a un attaccapanni diverso in una città diversa,
la durata con tuo figlio
ti può cogliere
ogni volta che rinchiuso da ore nella stanza
con un lavoro che ti sembra utile,
senti quello che nel silenzio ancora mancava alla giustezza del tutto,
il rumore della porta che si apre,
segno del suo ritorno a casa,
che in quel momento a te,
il piú sensibile ai rumori tra i sensibili ai rumori,
se proprio in quel momento stavi attento,
risuona come la musica piú bella.
E tu senti la durata con il tuo discendente
nel modo piú intenso forse
quando ti rendi invisibile
osservandolo di nascosto lungo la strada di ogni giorno,
quando precedi l’autobus in cui è salito
per poi veder passare,
tra una fila di estranei dietro al finestrino
quell’unico viso familiare
o quando semplicemente ti immagini da lontano
di vederlo fra gli altri, protetto dagli altri,
rispettato dagli altri
nella calca della metropolitana.
Per questi momenti della durata
il canto si concede un’espressione particolare:
essi ti coronano di stelle.
Ma anche continuare per anni a essere ben disposto nei tuoi confronti
può darti durata.
Sapermi guardare amichevolmente negli occhi
talvolta mi assolve.
Essere capace di pensare al bambino
che ero,
significa già ritrovarlo.
Essere indulgente con i miei difetti
(non con i miei eccessi)
rabbonirmi, se mi viene fatto un torto,
come mio unico parente,
battermi il petto
in trionfo per una parola felice
al posto giusto
e urlare un «sí» nella foresta della mia stanza
può ringiovanirmi
come una bottiglia di prelibatissimo vino
(con effetto però diverso).
Singolare è il sentimento della durata
anche alla vista di certe piccole cose
quanto meno appariscenti, tanto piú toccanti:
un cucchiaio
che mi ha accompagnato in tutti i traslochi,
un asciugamano
appeso nelle stanze da bagno piú diverse,
la teiera e la sedia di vimini
per anni lasciata in cantina
o accantonata da qualche parte
e ora finalmente di nuovo al suo posto,
un altro, in verità, diverso da quello originario
e tuttavia al suo posto.
E infine:
felice chiunque abbia i propri luoghi della durata!
Egli, anche se venisse portato lontano
senza prospettive di ritorno nel suo mondo,
non sarà piú un esule.
E anche i luoghi della durata non rifulgono di splendore,
spesso non sono nemmeno riportati sulle carte
oppure sono senza nome.
Il «lago di Griffen» è del tutto sconosciuto a chi viene da fuori,
ma anche certi bambini del mio paese nativo
oggi non sanno piú
che nelle loro vicinanze vi è un lago
di cui tra le due guerre
esistevano ancora cartoline con ninfee
e la stampigliatura «Griffen sul lago di Griffen».
E tuttavia questo stagno che va prosciugandosi
e che ben presto dovrebbe sparire
– cosí pensano i progettisti dell’autostrada –,
è per me un grande luogo della durata.
Da bambino vi accompagnavo il nonno
a tagliare foraggio.
Il lago si trovava dopo la strada asfaltata
e poi oltre la «strada vecchia» di ghiaia,
celato in un avvallamento ai piedi di quella montagna
che dà il nome a una battaglia del Medioevo
«la battaglia del Wallersberg»
e che tantissime volte ho esplorato
cercando resti arrugginiti di armi
di quel quattordicesimo secolo.
Ci staccavamo dalla riva
su una barchetta quasi quadrata
che in dialetto si chiamava Schinakel
e con una pertica ci inoltravamo tra i fitti giunchi sino al punto
dove si estendeva la zona che avevamo in affitto
e dove c’erano quelle piante acquatiche verdognole e succose
da noi chiamate Hasch, uno dei mangimi preferiti dalle mucche,
che dà un buon sapore al latte.
In questo momento ne ho un gambo, essiccato da tempo,
accanto a me sulla scrivania
raccolto in tutt’altro lago,
il lago di Doberdò vicino a Trieste,
l’unico lago del Carso.
E questo gambo nelle mie mani scricchia
e io sento di nuovo le prime gocce di pioggia di allora
cadere nella nostra barchetta.
È maculato o forse soltanto muffito
e appena lo rompo
ne esce fuori polvere
con un odore dolce, piú dolciastro di qualsiasi paglia
e che mi fa sentire ancora adesso il ruminare dei manzi.
Quei raccolti si facevano d’estate all’alba
con la falce
e durante una di queste uscite
a casa la moglie malata di quel vecchio
aveva esalato in silenzio il suo ultimo respiro.
Col tempo la barchetta faceva acqua
e dalle fessure filtrava fanghiglia nera
con dentro sanguisughe
che il nonno applicava al bambino e a se stesso
sulle gambe da servo tutte bianche
perché faceva bene:
e si aspettava il momento
in cui quelle bestie piccole come vermi
incollate alla pelle
si attaccavano con una forte puntura
rigonfiandosi a vista d’occhio
per diventare piú grandi di lumache senza guscio.
Oggi il ruscello che attraversa il lago è canalizzato
e quello che resta dello stagno
è celato alla vista da giunchi e sterpaglie.
La barchetta di famiglia ha attraversato il confine
ed è arrivata sino al lago di Doberdò, ovvero nello sloveno del luogo Doberdobsko jezero,
dove è un bastone di ontano a servire da remo
e gli insetti che corrono veloci sull’acqua sostituiscono le sanguisughe.
Tuttavia su entrambi questi laghi regna
lo stesso soave silenzio della durata
e tutte le volte che posso vado in pellegrinaggio di qua o di là.
Nel silenzio di questi laghi
so cosa faccio
e sapendo cosa faccio
so chi sono.
Sto sulle loro rive
con occhi e orecchi aperti
e lascio che cali la sera.
Vari sono i rumori degli uccelli acquatici
grazie ai quali il silenzio diventa piú vasto.
Io imparo dal silenzio.
Nel folto, impresse nel terreno fangoso,
profonde tracce di animali.
Un giorno, nel mio amore per il lago di Griffen,
risalivo a grandi passi il torrentello che lo attraversa
– per passare il lago non c’è altra via –
e intorbidivo con i miei passi l’acqua limpida;
nubi di sabbia risalivano dal fondo
rilucenti di mica
sino a cingermi i fianchi,
granellini d’argento, forse destinati
al Mar Nero.
Invece,
al contrario di questo lago che va sparendo,
la Porte d’Auteuil è indicata su ogni pianta di Parigi:
è importante perché è una delle porte occidentali della città,
ma per me con gli anni è diventata molto di piú.
Numerose strade urbane da est, nord e sud
confluiscono qui in una larga piazza a curva
che si attraversa per andare
verso Boulogne, Saint-Cloud e Versailles
e di lí in Normandia e al mare,
come preannunciano senza posa
l’ininterrotto fragore e il rimbombo del traffico
– e anche lo sferragliare di vecchi treni in una piccola stazione di testa –
sotto quel cielo ai margini della città,
mentre ciò che si vede oltre la piazza
a tutta prima è solo il Bois de Boulogne
con i suoi pinastri, cedri e platani altissimi,
come se la Porte d’Auteuil fosse un passaggio immediato
dalla metropoli alla foresta tropicale.
Anche questo posto lontano da casa
è diventato, come il lago di Griffen,
un mio luogo di pellegrinaggio laico
dove di tanto in tanto mi reco
perché qui mi aspetto il prodigio della durata
(senza ovviamente esserne certo).
Per la vicinanza dello stadio del Parco dei Principi
e dell’ippodromo
la Porte d’Auteuil non ha niente di tipicamente parigino;
la «Epsom Tavern» è un locale di periferia,
c’è un negozio di articoli sportivi dopo l’altro
e quei possenti tetri casermoni borghesi
potrebbero stare a Milano.
Questo posto è
– premessa forse dell’evento della durata? –
un perfetto modello dell’ogni dove.
La notte, mentre l’acqua scorre nelle cunette,
sui platani penzolano come palline le infruttescenze,
i cespugli di ligustro stormiscono
e nello spazio nero della notte
incessanti scattano
i colori dei semafori
come un flipper
con cui non mi stanco mai di giocare
e da ogni direzione sfrecciano come prendendo aria
le macchine e gli autobus
con i loro fanali francesi gialli
e chi osserva sente sotto la pianta dei piedi
tremare l’asfalto.
Pur essendo venuto in questo luogo
soltanto a trent’anni,
per me è come se qui avessi trascorso la mia giovinezza
e continuassi ancora a passarla qui
e anche tutte le avversità
– il mio girovagare attorno alla piazza con la paura nel cuore,
i carri armati che rintronano durante le feste nazionali
e solcano e lacerano il manto stradale,
i tifosi di calcio ubriachi attaccati alle loro bottiglie di whisky,
un automobilista
che salta fuori dalla sua vettura
per puntare la pistola contro il suo avversario –
non riescono a togliermi la fiducia in questo luogo della durata.
Desidero sentirvi spesso l’afflato della durata.
Ma il luogo principale della durata per me
è la Fontaine Sainte-Marie
nel bosco ai margini di Clamart e Meudon.
Sgorga in una radura del bosco,
in un triangolo d’erba formato da vie che si incrociano,
con una piccola trattoria sullo sfondo, un locale con giardino,
una costruzione in pietra tinteggiata di rosso all’esterno,
accogliente all’interno,
da cui d’estate e d’inverno si può vedere la sorgente,
la radura e una strada rialzata di terra gialla
che va verso l’orizzonte.
Se mi chiedessero dove sia per me il centro del mondo
direi la Fontaine Sainte-Marie.
E in effetti essa è un centro;
vi facevo sempre una sosta
passando per il bosco
quando venivo dal sobborgo di Clamart
per andare al sobborgo successivo di Meudon
a prendere la bambina a scuola
e ora rifaccio quel percorso
ogni volta che posso.
Nella vicina Parigi scorre la Senna,
le acque scorrono nelle cunette,
ma per il resto tutt’intorno nulla.
Quei pochi ruscelli d’un tempo
scorrono sotterranei ricoperti dal cemento.
Nella Fontaine Sainte-Marie
ho trovato l’unica sorgente di questa metropoli,
l’unico rivolo vivo, naturale.
Quando mi avvicino a questo luogo,
mai scendendo da un veicolo,
sempre a piedi,
già sul limitare del bosco
posso sperare nell’incanto
in cui ogni mio rimuginare si dissolve
e il mio pensare diviene un puro riflettere sul mondo.
Le chiacchiere dentro di me,
un tormento fatto di molte voci,
lasciano il campo alla meditazione,
una sorta di silenzio redentore,
dal quale poi arrivando in quel luogo
s’innalza un pensiero esplicito, il mio pensiero piú elevato:
salvare, salvare, salvare!
In una scossa cosí dolce quanto violenta
gli occhi si spalancano,
sento uno stridio negli orecchi
e celebro nella radura
la festa del ringraziamento per l’esistenza di questo luogo.
Il doberman nero ripiegandosi sulle zampe
può ora tranquillamente fiutarmi dietro le ginocchia.
In certi giorni la trattoria è chiusa,
in certe stagioni la sorgente è asciutta,
– forse presto finirà per sempre sotto il cemento –,
ma questo non ha nessuna importanza:
eccolo qui, il luogo della durata
dove io, allora come adesso, descrivo la mia parabola,
la terra raffigurata dal cespuglio di nocciolo adorno di amenti
agli inizi di primavera,
l’umanità rappresentata dalla donna
che sulla strada rialzata davanti al lungo muro
sospinge verso l’orizzonte la carrozzella col bambino.
Arthur, l’ultima volta che venni a Parigi
eravamo d’accordo
di andare di nuovo insieme alla Fontaine Sainte-Marie.
Ma poi, arrivato lí con te,
dopo una buona ora passata insieme,
ebbi l’impulso, contrariamente a quanto deciso,
di continuare la strada da solo
e ti ho mandato a casa.
Tu avevi capito
– traduttore non di professione
ma di cuore,
compagno nel pensiero, attore del testo, amico –
senza bisogno di spiegazioni, ridendo e facendo cenni
te ne tornasti trotterellando in città
alla tua Porte des Lilas, la porta orientale, la porta dei lillà,
anche tu, come me, sentivi il desiderio,
di stare da solo in compagnia della durata.
Sí, Fontaine Sainte-Marie o Porte des Lilas,
voi siete amate.
Ma viaggiare di persona,
andare ogni anno come in pellegrinaggio e per devozione
per sentirmi scosso dalla durata,
questo supplemento di entusiasmo
mi è veramente ancora necessario?
Ricordati della punta di invidia provata
tutte le volte che per le strade della città in cui abiti,
dove dai tempi degli arcivescovi lo spirito è messo al bando,
vedevi quella gente con bagaglio leggero
andare verso la ferrovia,
ricordati come ti stringeva il cuore
immaginando di stare seduto nell’aereo della sera
che virando verso ovest disegnava nel cielo la sua scia.
Nel frattempo non sento piú il bisogno di fare lunghi viaggi
verso i luoghi della durata.
Anche nell’assenza, improvvisamente,
quando me la prendo comoda,
avvitando tranquillamente una lampadina,
soppesando una pietra con la mano,
maneggiando qualcosa con cura,
si impadronisce di me, forse,
il silenzio frusciante del lago di Griffen,
nel Residenzplatz col suo scampanellio di carrozzelle
arriva il frastuono e il flusso ondeggiante della Porte d’Auteuil,
mi risollevo senza piú età
ritrovandomi nel triangolo della Fontaine Sainte-Marie.
Mi sono educato
ad attendere la durata
senza la fatica del pellegrinare.
Eppure il semplice starsene a casa non basta;
io devo andare incontro alla durata.
Andare incontro a ciò che mi è caro
o dirigermi in quel senso
mi dà fiato
in modo piú forte e piú durevole di una corsa di resistenza.
Non a chi sta seduto a casa
ma al viandante sul cammino del ritorno
si avvicina la durata
come a Odisseo bisognoso d’aiuto
la sua divina amica Pallade Atena.
Ma anche a casa mi si fa accanto molte volte
quando cammino su e giú per il giardino
nella neve, nella pioggia, al sole, sotto il temporale,
guardando il bosso ondeggiante,
l’albero di tasso trapunto di tele di ragno,
gli uccelli c0he si tuffano nell’aria,
quegli uccelli del cielo
che secondo lo Zohar «guidano la voce»,
oppure quando mi siedo nella mia stanza
al cosiddetto tavolo da lavoro –
non per attendere alla mia occupazione, al testo,
ma per fare tutti quei soliti gesti secondari:
spostare indietro la sedia,
dare uno sguardo nel cassetto
con i mozziconi di matita raccolti nel corso degli anni,
dare uno sguardo allo scaffale
con la fila di occhiali che aumenta nel corso degli anni,
sbirciare dalla finestra in giardino
dove i gatti lasciano le loro tracce
nella neve profonda e tra l’erba alta,
mentre ascolto da diverse direzioni a seconda del vento
il fischio e il trabalzare
dei treni che percorrono la pianura.
O durata, mia quiete!
O durata, mia sosta!
O scossa della durata nel tempo
tu mi circondi con uno spazio descrivibile
e già descriverlo crea i suoi nuovi spazi!
Resta vero:
la durata non è un’esperienza collettiva.
Essa non forma un popolo.
E tuttavia nello stato di grazia della durata
finalmente non sono piú io solo.
La durata è il mio riscatto,
mi lascia andare ed essere.
Animato dalla durata
io sono anche quegli altri
che già prima di me sono stati sul lago di Griffen,
che dopo di me gireranno attorno alla Porte d’Auteuil
e tutti quelli con cui sarò andato
alla Fontaine Sainte-Marie.
Sostenuto dalla durata,
io, essere effimero,
porto sulle mie spalle i miei predecessori e i miei successori,
un peso che mi eleva.
Per questo la durata doveva essere chiamata una grazia,
le sue immagini e i suoi suoni
non hanno forse quel bagliore e quel tono che ci si aspetta?
La pioggia serale che cade nella pozzanghera del mattino,
i fiocchi di neve sospinti nella teiera,
le scritte sempre uguali sui camion dei corrieri
che sfrecciano sul ponte dell’autostrada sopra la Salzach.
La scossa della durata
già di per sé intona un canto,
dà un ritmo senza parole
che,
elemento scatenante,
nelle mie vene fa battere il palpito di un epos
in cui alla fine il bene trionferà.
Quando la durata vi impone le mani
si chiude la ferita
di cui mi accorgo
solo quando si sta rimarginando.
Il pungolo della durata è ciò
che mi è mancato.
Chi non ha mai provato la durata
non ha vissuto.
La durata non stravolge,
mi rimette al posto giusto.
Senza esitazione rifuggo la luce abbagliante dell’accadere quotidiano
e mi riparo nell’incerto rifugio della durata.
Durata si ha quando
in un bambino
che non è piú un bambino
– e che forse è già un vecchio –
ritrovo gli occhi del bambino.
Durata non c’è nella pietra immortale,
preistorica,
ma dentro il tempo,
nel morbido.
Lacrime di durata, troppo rare!,
lacrime di gioia.
Incerte, non invocabili,
non implorabili
scosse della durata,
custodite ora siete
in un canto.
Peter Handke
Salisburgo, marzo 1986.
(Traduzione di Hans Kitzmüller)
“Canto alla durata”, Einaudi, Torino, 2016
“Gedicht an die Dauer”, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1986