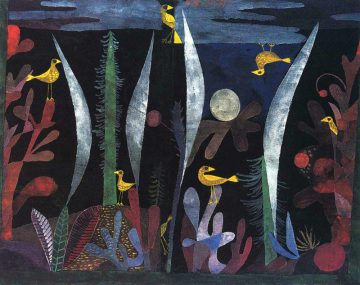Foto di Danilo De Marco
O me donzel! Jo i nas ta l’odòur che la ploja a suspira tai pras di erba viva… i nas tal spieli da la roja.
P. P. Pasolini
I
Di insom tant che lusôr
o tant che ’ne montane
la gnot, la nere, e frue
chel pôc di cîl ch’al trame.
E rue par rue dal cîl
denant, daûr dal dì
ta fueis di chest aiâr
e poe la man felpade.
Dî sì, tu sês l’agâr,
la roe ch’e sgote in nuie
chel ch’o vin dit o fat
bessôi, cence savê
se dî di sei par pierdisi
o pierdisi par sei.
Dall’alto come lucore o quanto un fiume in piena la notte, la nera, consuma quel poco di cielo che trema. E piega per piega dal cielo, davanti, dietro il giorno, nelle foglie di questo acero posa la sua mano felpata. Dire sí, tu sei l’acquaio, la roggia che sgocciola nel nulla quel che abbiamo detto o fatto da soli, senza sapere se dire di essere per perdersi o perdersi per essere.
II
Sium, sium dentri inte sium
lûs di ce che nol è
e vôs di chel ch’al jere
neri butul de gnot
ch’al impromet sflandôr
tiere fate di niule
niule fate ladrîs
man çampe inte man drete
sium cjapimi me sium
cjampanule di scûr
flamule benedete
declinazion di poete
ch’al impromet amôr
e ôr dal ôr e gnot.
Sogno, sogno dentro il sonno, luce di ciò che non c’è e voce di quello che c’era, nero bocciolo della notte che promette splendore, terra fatta di nuvola, nuvola fatta radice, mano sinistra dentro la destra, sogno, prendimi pure, sogno, campanula di buio, fiammella benedetta, declinazione di poeta che promette amore e orlo d’orlo e notte.
III
Donzel, la gnot plui biele
e je chê ch’e mi tâs
dentri, minude come
un centesim di pâs
te sachete dal cûr
dulà che il cuart di lune
intal cidin dal cîl
al lûs come un rincjin
e la maràngule e rît
che, frut, faseve pôre
e al tâs il crît dal dì
e nô no si è plui nô
e il dolç mancjâsi dentri
nol è ancjemò durmî.
Donzel, la notte piú bella è quella che mi tace dentro, minuta come un centesimo di pace dentro la tasca del cuore, dove il quarto di luna nel silenzio del cielo brilla come un orecchino e il gattomammone sorride, che da bambino faceva paura, e tace l’urlío del giorno e noi non si è piú noi e il dolce cadersi dentro non è dormire ancora.
IV
Achì soi jo, par dentri
une gnot che no je
e cidin tal cidin
florît di piere e gno.
Achì soi jo, a scurîmi
cul scurîsi de gnot
frescje e scuride ator
ator come di scune.
Achì soi jo, ch’o strenç
lis mans tor dai zenôi
i zenôi dongje il cûr
dentri il cercli dai vôi
il cercli da la lune
fin a vignî bambin.
Io sono qui, dentro una notte che non c’è e silenzioso nel silenzio fiorito di pietra e mio. Io sono qui, a scurirmi con lo scurirsi della notte fresca e scurita intorno come di culla. Io sono qui, che stringo le mani alle ginocchia, le ginocchia accanto al cuore, dentro il cerchio degli occhi il cerchio della luna fino a tornare bambino.
V
“E jo cjanti, cjanti, cjanti
e no sai bielsôl parcè.
E jo cjanti solamentri
che par consolâmi me”.
Un rai – il prin – di soreli
mancul che une cjarece
sofli d’aur o cjaveli
te miezegnot dal cûr;
un rai cerçât sul ôr
di veri da la tace
cul tenar dai miei lavris
tal neri dal cafè;
un rai ch’al sedi screi
se no ancjemò lusôr
o buinore dai vîfs
tal screi di vierte d’aur;
un rai – chest prin – ch’al è
par colorâmi me.
Un raggio – il primo – di sole, meno che una carezza, soffio d’oro o capello nella mezzanotte del cuore; un raggio gustato sull’orlo di vetro del bicchiere col tenero delle mie labbra nel nero del caffè; un raggio che sia il primo segno se non ancora luce o la buonora dei vivi nell’apertura d’oro della primavera; un raggio – questo primo – che sta per colorare me.
VI
Dî ch’al è vert il vert
no mi samee, di plui
mi môf se il ros de fuee
ros tal amont di Lui
al va e al ven tal vert
cul lâ e tornâ dal vint
cussì nol è plui vert
il vert nì fuee la fuee
ma ros di cûr ch’al trime
batiât dentri l’arint
da li’ stelis: ma velis
– li’ stelis – maravee
su la gnot dai vignâi
il colôr dai colôrs.
Dire che è verde il verde non mi assomiglia, di piú mi muovo se il rosso della foglia, rosso nel tramonto di luglio, va e viene nel verde con l’andare e il tornare del vento, cosí non è piú verde il verde né la foglia foglia ma rosso di cuore che trema battezzato dentro l’argento delle stelle: ma eccole – le stelle – meraviglia sulla notte dei vigneti il colore dei colori.
VII
Tal cjalt, tal sîr rabiôs
te briscule incjocade
dai temporâi d’Avost
no viôt començament
Donzel, anime magre,
peraule di cjatâ;
mi vûl une rosade
disore cheste sagre
di cartelons e spots
e trends e leasings, bars
e marketings e stops
che, cotulis di bande,
a balin di lusôr
parsore il cidinôr.
Nel caldo , nel siero rabbioso, nella briscola ubriacata dei temporali d’agosto non vedo cominciamento, Donzel, anima magra, parola da trovare; mi serve un velo rorido sopra questa sagra di cartelloni e spot e trend e leasing, bar e marketing e stop, che come gonne di latta ballano di luccichío sopra il silenzio.
VIII
Oh, cjale chest Setembar
cjale jenfre e parsore
il plan cemût ch’al vîf
e che s’inflame e indore
e cjalilu stinît
sul ôr sul fîl d’atom
ch’al cjante e si distude
ta ruis di chest morâr;
alore scrîf e clâr
scrivimilu sul fuei
che muart tant che puisie
di ducj nome un vistît
un sôl e mi domande
ma chel ch’al è plui biel.
Oh, guarda questo settembre, guarda nel mezzo e sopra la pianura com’è che vive e che s’infiamma e indora, e guardalo allibito sull’orlo, sul filo dell’autunno che canta e che si spegne nelle pieghe di questo gelso; allora scrivi e scrivimelo sul foglio chiaramente, che sia morte che poesia, di tutti soltanto un abito, uno solo me ne richiede, ma quello che è piú bello.
IX
Jo, ch’o ti samei a mi
ma par semeâmi miôr
semence mai vignude
a flôr, fuei vueit, intîr
misure dal pinsîr
ch’al nas e al mûr tal blanc
gjespe ch’e svirgulee
e spiç tal flanc di arsenic;
jo, ch’o soi ma no soi
ce ch’o soi stât, ch’o stoi
– cumò ch’o soi – ma come
ch’o fos ce ch’o sarai
vuê o ti consegni un fuei:
chest al è il plen, il vueit.
Io, che ti assomiglio a me, ma per assomigliarmi meglio, semenza mai venuta a fiore, foglio vuoto, intero, misura del pensiero che nasce e muore nel bianco, vespa che svirgola e stocco d’arsenico nel fianco; io, che sono, ma non sono quel che sono stato, che sto – adesso che sono – ma come fossi quel che sarò, oggi ti consegno un foglio: questo è il pieno, il vuoto.
X
Vuê ch’al è unvier di frêt
spieli di frêt sul fuei
e il cûr mi trimulee
come un ramaç discolç;
vuê che dî al è partî
e amôr di me s’innee
fra la peraule dite
e chê ancjemò di dî;
scoltimi ben che ben
jo o sai murîmi a mi
Donzel, numar d’amôr:
fra me e me anime mê
soi jo che o sighi jo
ta l’aur dal cidinôr.
Oggi che è inverno di freddo, specchio di freddo sul foglio, e il cuore trema come un ramo scalzo; oggi che dire è partire e amor di me si annega tra la parola detta e quella ancora da dire; ascoltami bene, che bene so morire a me, Donzel, cifra d’amore: fra me e me anima mia ci sono io che grido io nell’oro del silenzio.
XI
Nol è nome nevere
di floc parsore floc
o blanc cidinorôs
par dispocâmi il poc
dal gno sintî dolôr,
il blanc da la nevere:
nì companie di glace
par disglaçâ la place
suturne dal gno cûr
o pûr il vueit dal grim;
ma chel dutun de tiere
un pas prime dal scûr
tal palidôr dal cîl
al è sigâ d’amôr.
Non è soltanto una nevicata di fiocco sopra fiocco o bianco silenzioso per spuntare lo stocco del mio sentire dolore, il bianco della nevicata: né compagnia di ghiaccio per disgelare la piazza amara del mio cuore oppure il vuoto del grembo; ma quel tuttuno della terra, un passo prima del buio nel pallore del cielo è gridare amore.
XII
Chel che tu viôts cumò
un passar nome passar
un pugn dutun cun sè
intal so sei di niule
coltade tai miei vôi
cressude spetenade
là ch’o comenci jo
om vîf intal gno sei
di cjar dentri intal frêt
di frêt dentri i cjavêi
di passar nome passar
ch’a mi à viodût cumò
doman, Donzel, tal frêt
cjantaràial inmò?
Quello che vedi adesso, un passero che è soltanto passero, un pugno tutto compreso in sé nel suo essere di nuvola coltivata nei miei occhi, cresciuta spettinata là dove comincio io, uomo vivo nel mio essere di carne dentro il freddo, di freddo dentro i capelli, di passero solo passero che mi ha scorto adesso, domani, Donzel, nel freddo canterà ancora?
XIII
Intal rivâl di jerbis
lizeris di Zenâr
e lungjis tant che il rai
che si distude in lôr
podê polsâ, polsâ…
tra dî e pensâ, sentât
sul nuie tirâ il flât
gjavâ scae sore scae
il mâl dai pas puartâts
e di puartâ ogni dì.
E po tornâ a partî
cu l’anime par troi
ch’al è vivâr di viers
amâr amâr amâr.
Su questo poggio d’erbe leggere di gennaio e lunghe quanto il raggio che si spegne in loro, poter riposare, riposare… tra il dire e il pensare, seduto sul nulla, riprendere fiato, levare scheggia dopo scheggia il male dei passi portati e da portare ogni giorno. E dopo ripartire, con per sentiero l’anima, che è vivaio di versi, amaro amaro amaro.
XIV
Jo o fâs fadìe par fâ
dut, fadìe par vistîmi,
Donzel, fadìe a mangjâ
fadìe a durmî e par fâ
l’amôr, fadìe a cjalâ
la zilugne a Fevrâr
come ch’e fos la prime
floride arbe d’Avrîl
fadìe a smenteâ
che di nô al restarà
un jevâsi intal scûr
cence fadìe un poiâsi
tal scûr, cul nuie devant,
cence nuie daûr.
Io faccio fatica per fare tutto, fatica a vestirmi, Donzel, fatica a mangiare, fatica a dormire e per fare l’amore, fatica a guardare la brina a febbraio come fosse la prima fiorita erba d’aprile, fatica a dimenticare che di noi resterà un levarsi nel buio senza fatica un posarsi nel buio, col niente davanti, senza aver niente dietro.
XV
Ce ch’o vorès restâ
Donzel, mancul che il plui
dismenteât dai oms
dispetenât salvadi
fradi dal prât poiât
su la verde lusere
dal prât, ce ch’o vorès
la caretât dal vint
a cjarinâmi mans
e çarneli, e cui vôi
çupâ lassù la polpe
fonde dal cîl, e dentri
sintî passâ la rabie
cuietade dal mâr.
Come vorrei rimanere, Donzel, meno che il piú dimenticato degli uomini spettinato e selvatico, fratello del prato posato sulla luce verde del prato, come vorrei la carità del vento a carezzarmi mani e fronte e con gli occhi succhiare lassú la polpa profonda del cielo, e dentro sentirmi attraversare la rabbia pacificata del mare.
XVI
Îr vuê dam e vuadagn
e l’un dentri intal doi
ma il doi che nol è l’un
e jo nì chest nì chel
spiâmi chel ch’o jeri
che no sarai doman;
îr vuê dam e vuadagn
denant al bruse l’îr
ma dentri intal doman
e ogni ricuart ch’al sedi
al lûs come un scarpion
îr vuê doman jo o scjampi…
“Tu scjamparessis sì
ma par tornâ indaûr”.
Ieri oggi danno e guadagno e l’uno dentro il due ma il due che non è l’uno e io né questo né quello, spiarmi quello che ero, che non sarò domani; ieri oggi danno e guadagno, davanti brucia lo ieri ma dentro il domani e ogni ricordo che sia dà luce come uno scorpione, ieri oggi domani scappo… “Tu scapperesti, sí, ma per tornare indietro”.
XVII
No savarès Donzel
fadìe, no savarès
l’imbast e chel daspâ
e chel tasêmi dentri
intal sec criçulâ
des cuestis, e il zimul
sfuarçâ da lis zimis
lis primis, a Fevrâr;
no savarès tal sanc
nì il cjalt dal cjaminâ
nì il fresc gotâ de polse
no savarès nuealtri
di me se no savès
di me che o soi forest.
Non saprei, Donzel, fatica, non saprei affanno e quello scalpitare e quel tacermi dentro nel secco scricchiolio delle costole e lo sforzo gemello delle gemme, le prime, a febbraio; non saprei nel sangue né il caldo del camminare né il fresco gocciolio della sosta, non saprei nient’altro di me se non sapessi di me che sono straniero.
XVIII
Vino di lâ, ma cuant
cumò? Che presonîrs
preson nô o sin di nô.
Cjalìn la muse lustre
dal vert tal zâl dal cîl
di vierte ch’e s’invere
ma o sin ancjemò dentri
cumò ch’al è sotsere.
Pierdûts in cheste vuere.
E pûr Donzel scoltìn
– no flôr nancje semence –
scoltìn il nestri pas
di çucule ch’e ròdule
ch’e ròdule par tiere.
Dobbiamo andare, ma quando, adesso? Che prigionieri siamo prigione di noi stessi. Guardiamo la faccia lucida del verde dentro il giallo del cielo di primavera che s’invera, ma siamo ancora dentro adesso sottosera. Perduti in questa guerra. Eppure ascoltiamo, Donzel – non fiore né semenza – ascoltiamo il nostro passo di pigna che rotola, che rotola per terra.
XIX
Lassaitmi cussì come
ch’o stoi cence rasons
cence vuadagn nì dam
doi vôi davierts ai fonts
rasonaments dal cîl
ch’al sta parcè che o stedi
fer cussì come ch’o stoi.
Lassaitmi achì ch’o sedi
la sissule plui scarte
ta l’aiarfuart di Avrîl,
il svoledon di cjarte
poiât tal vert dal prât,
la maravee dal frut
ch’al dîs ch’al à svolât.
Lasciatemi cosí come rimango, senza ragioni, senza guadagno né danno, due occhi aperti ai fondi ragionamenti del cielo che sta perché io stia fermo cosí come rimango. Lasciatemi qui, che io sia la scheggia piú a buon prezzo dentro l’ariaforte di aprile, l’aeroplano di carta posato nel verde del prato, la meraviglia del bambino che dice che ha volato.
XX
Un murmui mi è l’aiar
chest chì lizêr di Avrîl,
vite cence semence
in tant gurgùi di vite
e vôs cence une muse
e mans ch’a mi son flôrs
sul blanc daviert des mês:
jo, ch’o puarti intal sanc
la miserie dai prâts
di Zenâr, vuê o mi soi
cjatât tal bonodôr
di savudâr, maravee
contentade tal stâ
dal cîl, achì difûr.
Un mormorio mi è il vento, questo qui leggero di Aprile, vita senza semenza in tanto rotolio di vita e voce senza viso e mani che mi sono fiori sul bianco aperto delle mie: io, che porto nel sangue la miseria dei prati a gennaio, oggi mi sono trovato nel buonodore di sambuco, meraviglia accontentata nel sostare del cielo, qua fuori.
XXI
Tal mieç da la planure
doi rôi e un cocolâr
plui in jù, oltri il soriâl
un rocul bandonât.
Disore cualchi ucel
sierât intune rie,
grignâi di nûi smavîts
e lûs che mi dislûs.
Disore lôr il cîl
ligul linçûl e grîs
chel tant di melodie
ch’a si displume in nuie
e jo ca jù cun te
Donzel, la sô ladrîs.
In mezzo alla pianura due roveri e un noce, piú giú, oltre i saggiuoli, un roccolo abbandonato. Sopra, qualche uccello chiuso in una fila, rovelli di nuvoli senza colore e luce che m’acceca. Sopra di loro il cielo, lenzuolo liso e grigio, quel po’ di melodia che si dispiuma in niente e io quaggiú con te, Donzel, la sua radice.
XXII
Fin cuant ch’a ’nd è ch’a ’nt vegni
di chestis soregladis
lizeris sui balcons;
un come me ch’al stedi
davûr di chestis lastris
dôs mans blancjis poadis
doi vôi sul lustri e il rusin
d’Avrîl jù pai vignâi
ogni pensîr dal mont
petenât di lusôr
denant di chestis lastris
come il butul dal flôr
il blancôr di chês niulis
fermis ta l’aiar, finis.
Fin quando ce n’è, ne vengano, di queste soleggiate leggere sulle finestre; uno come me stia pure dietro queste lastre, due mani bianche posate, due occhi sul lucido e sull’ossido d’aprile per vigneti, ogni pensiero del mondo pettinato di luce davanti a queste lastre come il bocciolo del fiore, il biancore di quelle nuvole, ferme nell’aria, sottili.
XXIII
Jerbe lescje il savôr
da la plui frescje niule
d’Avrîl vuê che Donzel
nuie, il mancul il plui
mancul inmò il compagn
lontanance di me
lontan no mi slontane;
jenfri il mont ch’al è il mont
e il cîl il cîl ch’o viôt
crepe di vueit mi son
inte spiete lis oris
a segnâ la mancjance
cul dam, come di dincj
te polpe di une pome.
Erba secca il sapore della piú fresca nuvola d’aprile oggi che, Donzel, niente, il meno il piú, meno ancora l’uguale lontananza di me, lontano, non mi allontana; tra il mondo che è il mondo e il cielo il cielo che vedo, crepa di vuoto mi sono nell’attesa le ore a segnare la mancanza col danno, come di denti nella polpa di un pomo.
XXIV
O vin dit dut, par dut
ma il dut al è ancjemò
cussì cumò ch’o viôt
chê sinfonie di jerbis
jerbe o soi ancje jo
se al baste aiar di Mai
par dî, cjantâ di sei
o nini o frut, Donzel.
Memorie e passe vie
par sot, magari sot
chest tei e l’armonie
dai nûi, ma, cualchi volte,
si distrie tant che brame
o lampe di cjavêi.
Abbiamo detto tutto, per tutto, ma tutto vuole dire ancora, cosí, adesso che vedo quella sinfonia d’erbe, erba sono anch’io se basta aria di maggio per dire, cantare d’essere o “nini” o “frut”, Donzel. Memoria scorre sotto, magari sotto questo tiglio e l’armonia dei nuvoli, ma qualche volta si dismaga quanto brama o lampo di capelli.
XXV
Oltri l’ôr di cheste taule
i doi balcons davierts
tal zucar dal soreli
sore verts e çarneli
une buinore nete
come la prime peraule
dal mont: sveâsi adore,
l’odôr de gnot intor
denant il bonodôr
madûr de primevere
cence dam nì travai
la cocule lusinte
da la zornade gnove,
vuê, trentedoi di Mai.
Oltre l’orlo di questo tavolo le due finestre aperte: nello zucchero del sole, sopra verdi e fronte una mattina pulita come la prima parola del mondo: svegliarsi di buonora, l’odore della notte addosso, davanti il buonodore maturo della primavera, senza danno né travaglio il nocciolo lucente della giornata nuova, oggi, il trentadue di maggio.
XXVI
O ài daviert i miei vôi
tai vôi colôr trist timp
dal cîl; lassù Donzel
nus menarà tampieste
tampieste e po tampieste
sul trimulâ dai flôrs:
inte prime sgoriade
di vint sore dai verts
o ài nasât cu l’odôr
da lis jerbis di ploie
l’odôr penç da l’amôr
come che amôr mi fos
il pês intîr di un cîl
sore il tenar di un flôr.
Ho aperto i miei occhi negli occhi color tempocattivo del cielo; lassú, Donzel, ci porterà tempesta, tempesta e poi tempesta sul tremolio dei fiori: nella prima frustata di vento sopra i verdi, ho annusato con l’odore delle erbe di pioggia l’odore denso d’amore, come se amore mi fosse il peso intero di un cielo sulla tenerezza di un fiore.
Pierluigi Cappello
da “Assetto di volo. Poesie 1992-2005”, Crocetti Editore, 2006