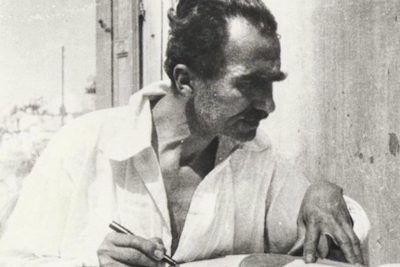Kaveh Hosseini, Vagueness
muoio disonorato cosí
davanti ai Greci
Sofocle, Aiace (v.440)
Sera d’estate. Salendo lungo l’erta
il passo rischia insidie ad ogni tratto
mentre lenti fendiamo due sipari
di querce e mirti, lecci e faggi in branchi
scolpiti come coltri d’ombra fitta.
E finalmente
le stanche vene arrivano
sul culmine di Tuscolo.
∗
Sotto sguardi coperti dalle stelle
brulica larga Roma che s’accende
in fiammelle di luci fino al mare.
∗
Muovendo accorti sopra al basolato
traversiamo l’orchestra del teatro
per sistemarci sulla gradinata
dove forse sedette il pensatore
che rintracciò la fonte del coraggio¹
nella contemptio mortis dolorisque.
Giunta notte, qui va a rappresentarsi
la tragedia di Aiace Telamonio.
∗
Vicenda della fine d’un eroe
quale altro mai si mosse verso Troia
fra tutti i Greci dalla lunga chioma²
nati da umani.
Il gigante dallo scudo invincibile
forte come ferro temprato,
Aiace
baluardo degli Achei dai gambali di bronzo
che scosse l’asta dalla lunga ombra
affamata di carne
contro Ettore, domatore di cavalli
frantumando il suo scudo con un masso
e arrestandosi sol perché alla notte
bisognava obbedire.
Ma nel delirio della sua possanza
il Telamonio
ebbe il torto di osare e profferire
parole di superbo, grave orgoglio
nei confronti di Atena
figlia di Zeus
e un rio disegno contro il suo valore.
Disegno che, nel rifiutargli
le invitte armi di Achille,
lo condusse a vendetta dell’affronto
per cieche indegnità nella follia
spingendolo a confondere le bestie
con i Greci da uccidere
e cosí
facendo strage di montoni e buoi.
Affondato nei poveri animali
l’oltraggio al proprio onore
tornò Aiace finalmente al senno
e oltre non volle sopportare l’onta
confidando al silenzio
il suo finale intento senza scampo
“Aiace, nel nome che mi dettero – ahi! ahi! –
già era presagio della sofferenza.
Mi odiano gli dèi, l’esercito dei Greci
e m’odia Troia. Ombra mia luce
tenebra splendente, prendimi nel tuo regno
vieni e prendimi.
Accorri morte mia guardami in petto.
Anche laggiú con te potrò parlare”.
Poi fermo
non raccogliendo il pianto di Tecmessa
si gettò sulla spada infissa a terra
e spegnendo la vita affrontò l’Ade.
E finí
l’uomo d’animo indomabile
cui sarebbe spettata ogni altra gloria
spinto invece su quel percorso osceno
che solo il bronzo poté riscattare.
∗
I grandi eroi sono il miglior bersaglio
dei voleri immanenti e ineludibili.
Pur se ognuno di noi viventi in terra
s’aggira da fantasma, ombra leggera
esposta ad ogni colpo degli eventi.
Poiché mai si è profeti del futuro
dal fato non sperare di proteggerti
se riso o pianto sono opera sua.
∗
Questo raccontò Sofocle ad Atene
emozionata
una sera dei secoli che furono.
Per quella amara fine
patiamo ancora adesso
noi misere creature del momento
quando il grande racconto ci conferma
che nessuna pietà coglierà mai
preghiere contrastate dal destino
e ogni lacrima si sperderà al vento.
∗
Nulla è di nuovo al mondo
né agli insulti del tempo. Mentre muti
abbandoniamo Aiace
nel suo onore perduto
e dal pendio scendiamo verso il chiosco,
ritorniamo fra giorni senza eroi
alle nostre ore spente
del povero viaggio che ci resta.
Lucio Mariani
Tuscolo, Argentario, 18-23/8/2010
da “Canti di Ripa Grande”, Crocetti Editore, 2013