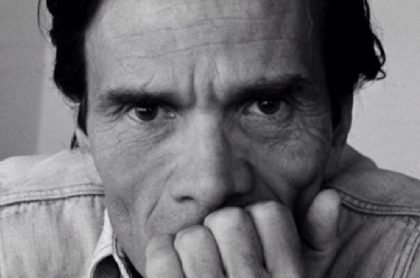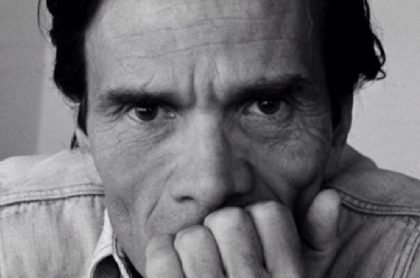
Alle volte è dentro di noi qualcosa
(che tu sai bene, perché è la poesia)
qualcosa di buio in cui si fa luminosa
la vita: un pianto interno, una nostalgia
gonfia di asciutte, pure lacrime.
Camminando per questa poverissima via
di Casarola, destinata al buio, agli acri
crepuscoli dei cristiani inverni,
ecco farsi, in quel pianto, sacri
i più comuni, i più inutili, i più inermi
aspetti della vita: quattro case
di pietra di montagna, con gli interni
neri di sterile miseria – una frase
sola sospesa nella triste aria,
secco odore di stalla, sulla base
del gelo mai estinto – e, onoraria,
timida, l’estate: l’estate, con i corpi
sublimi dei castagni, qui fitti, là rari,
disposti sulle chine – come storpi
o giganti – dalla sola Bellezza.
Ah bosco, deterso dentro, sotto i forti
profili del fogliame, che si spezzano,
riprendono il motivo d’una pittura rustica
ma raffinata – il Garutti? il Collezza?
Non Correggio, forse: ma di certo il gusto
del dolce e grande manierismo
che tocca col suo capriccio dolcemente robusto
le radici della vita vivente: ed è realismo…
Sotto i caldi castagni, poi, nel vuoto
che vi si scava in mezzo, come un crisma,
odora una pioggia cotta al sole, poco:
un ricordo della disorientata infanzia.
E, lì in fondo, il muricciolo remoto
del cimitero. So che per te speranza
è non volerne, speranza: avere solo
questa cuccia per le mille sere che avanzano
allontanando quella sera, che a loro,
per fortuna, così dolcemente somiglia.
Una cuccia nel tuo Appennino d’oro.
La Guinea… polvere pugliese o poltiglia
padana, riconoscibile a una fantasia
così attaccata alla terra, alla famiglia,
com’è la tua, e com’è anche la mia:
li ho visti, nel Kenia, quei colori
senza mezza tinta, senza ironia,
viola, verdi, verdazzurri, azzurri, ori,
ma non profusi, anzi, scarsi, avari,
accesi qua e là, tra vuoti e odori
inesplicabili, sopra polveri d’alveari
roventi… Il viola è una piccola sottana,
il verde è una striscia sui dorsali
neri d’una vecchia, il verdazzurro una strana
forma di frutto, sopra una cassetta,
l’azzurro, qualche foglia di savana
intrecciata, l’oro una maglietta
di un ragazzo nero dal grembo potente.
Altro colpo di pollice ha la Bellezza:
modella altri zigomi, si risente
in altre fronti, disegna altre nuche.
Ma la Bellezza è Bellezza, e non mente:
qui è rinata tra anime ricciute
e camuse, tra pelli dolci come seta,
e membra stupendamente cresciute.
Il mare è fermo e colorato come creta:
con case bianche, e palme: «tinte forti
da tavolozza cubista», come dice un poeta
africano. E la notte! Sensi distorti
da ogni nostro dolce costume,
occorrono, per cogliere i folli decorsi
che accadono, come pestilenze, a queste lune.
Perduti dietro metropoli di capanne
in uno spiazzo tra palme nere come piume,
alberi di garofano, di cannella – e canne
uguali alle nostrane, quelle sparse intorno
a ogni umano abitato – come tre zanne,
tre strumenti suonati quasi dal fuoco di un forno
inestinguibile, da gote nere sotto le falde
dei cappelli flosci presenti a ogni sbornia –
urlavano sempre le stesse note di leopardi
feriti, una melodia che non so dire:
araba? o americana? o arcaici e bastardi
resti di una musica, il cui lento morire
è il veloce morire dell’Africa?
Questo terzetto era al centro, scurrile
e religioso: neri-fetenti come capri
i tre suonatori, schiena contro schiena,
stretti, perché, intorno, in due sacri
cerchi di pochi metri, rigirava una piena
di migliaia di corpi. Nel cerchio interno
erano donne, a girare, addossate, appena
sussultanti nella loro danza. All’esterno
i maschi, tutti giovani, coi calzoni
di tela leggera, che, intorno a quel perno
di trombe, stranamente calmi, buoni,
giravano scuotendo appena spalle e anche:
ma ogni tanto, con fame di leoni,
le gambe larghe, il grembo in avanti,
si agitavano come in un atto di coito
con gli occhi al cielo. Al fianco
le donne, vesti celesti sopra i neri cuoi
delle pelli sudate, gli occhi bassi,
giravano covando millenaria gioia…
Ah, non potrò più resistere ai ricatti
dell’operazione che non ha uguale,
credo, a fare dei miei pensieri, dei miei atti,
altro da ciò che sono: a trasformare
alle radici la mia povera persona:
è, caro Attilio, il patto industriale.
Nulla gli può resistere: non vedi come suona
debole la difesa degli amici laici
o comunisti contro la più vile cronaca?
L’intelligenza non avrà mai peso, mai,
nel giudizio di questa pubblica opinione.
Neppure sul sangue dei lager, tu otterrai
da una dei milioni d’anime della nostra nazione,
un giudizio netto, interamente indignato:
irreale è ogni idea, irreale ogni passione,
di questo popolo ormai dissociato
da secoli, la cui soave saggezza
gli serve a vivere, non l’ha mai liberato.
Mostrare la mia faccia, la mia magrezza –
alzare la mia sola, puerile voce –
non ha più senso: la viltà avvezza
a vedere morire nel modo più atroce
gli altri, con la più strana indifferenza.
Io muoio, ed anche questo mi nuoce.
Nulla è insignificante alla potenza
industriale! La debolezza dell’agnello
viene calcolata ormai più senza
fatica nei suoi pretesti da un cervello
che distrugge ciò che deve distruggere:
nulla da fare, mio incerto fratello…
Mi si richiede un coraggio che sfugge
del tutto al reale, appartiene ad altra storia;
mi si vuole spelacchiato leone che rugge
contro i servi o contro le astrazioni
della potenza sfruttatrice:
ah, ma non sono sport le mie passioni,
la mia ingenua rabbia non è competitrice.
Non c’è proporzione tra una nuova massa
predestinata e un vecchio io che dice
le sue ragioni a rischio della sua carcassa.
Non è il dovere che mi trattiene a cercare
un mondo che fu nostro nella classica
forza dell’elegia! nell’allusione a un fatale
essere uomini in proporzioni umane!
La Grecia, Roma, i piccoli centri immortali…
Un’ansia romantica che pareva esanime
sopravvivenza, mostruosamente s’ingrandisce,
occupa continenti, isole immani…
annette Dei di milioni di guadi, percepisce
l’odore dell’umidità dei quaranta gradi
sopra zero immobili nelle coste, Mogadiscio
e le buganvillee di Nairobi, gli odori bradi
delle bestiacce scomposte in un selvatico
galoppo, per gli sventrati, i radi
orizzonti pervasi d’un funebre stallatico;
la quantità, l’immensità che pesa
inutilmente nel mondo, i cui prati bruciati
o marci d’acqua, sono una distesa
priva di possibile poesia, rozza cosa
restata lì, ai primordi, senza attesa,
sotto un sole meccanico che, annosa
e appena nata, essa subisce come infinità.
Ne nasce un bestiale colore rosa
dove il sesso paesano che ognuno ha
disegnato in calzoni di allegro cotone,
in gonne comprate negli stores indiani,
con soli occhiuti e cerchi di pavone,
come un’isola galleggia in un oceano
ronzante ancora per un’esplosione
recente e sprofondata dentro le maree…
Fiori tutti d’un colore, di cotone,
occhiuti e cerchiati popolano le Guinee
galleggiando nel tanfo d’un’uccisione,
nella carne delle estati sempre feroce
a divorare cibi cui la notte impone
le tinte equatoriali della morte precoce,
il blu e il viola e la polvere orrenda,
la libertà, che partorisce il popolo con voce
famigliare, e, in realtà, tremenda,
il nero dei villaggi, il nero dei porti coloniali,
il nero degli hotels, il nero delle tende…
E… alba pratalia, alba pratalia,
alba pratalia… I prati bianchi!
Così mi risveglio, il mattino, in Italia,
con questa idea dei millenni stanchi
bollata nel cervello: i bianchi prati
del Comune… della Diocesi… dei Banchi
toscani o cisalpini… quelli rievocati
nel latino del duro, dolce Salimbene…
Il mondo che sta in un testo, gli Stati
racchiusi in un muro di cinta – le vene
dei fiumi che sono poco più che rogge,
specchianti tra gaggìe supreme
– i ruderi, consumati da rustiche piogge
e liturgici soli, alla cui luce
l’Europa è così piccola, non poggia
che sulla ragione dell’uomo, e conduce
una vita fatta per sé, per l’abitudine,
per le sue classicità sparute.
Non si sfugge, lo so. La Negritudine
è in questi prati bianchi, tra i covoni
dei mezzadri, nella solitudine
delle piazzette, nel patrimonio
dei grandi stili – della nostra storia.
La Negritudine, dico, che sarà ragione.
Ma qui a Casarola splende un sole
che morendo ritira la sua luce,
certa allusione ad un finito amore.
Pier Paolo Pasolini
da “Poesia in forma di rosa (1961-64)”, Milano, Garzanti, 1964